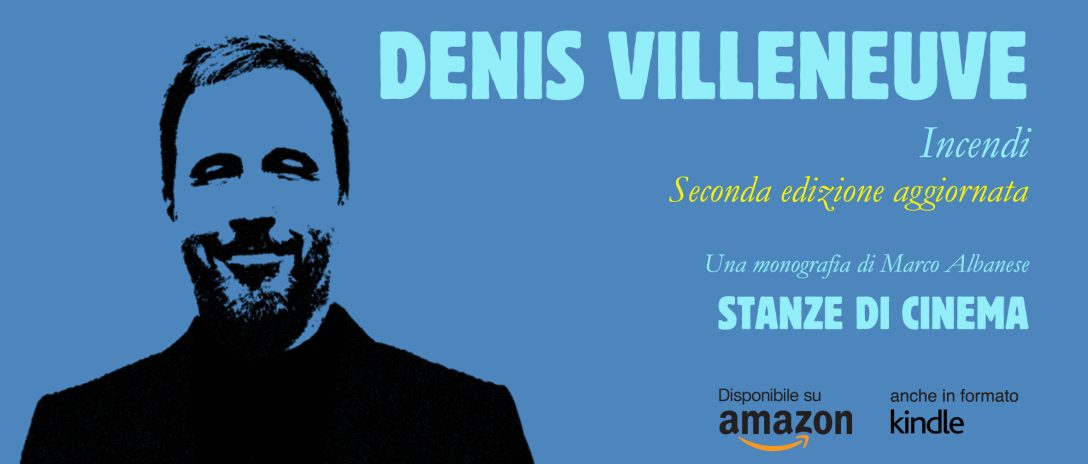Un piede che sbatte incessantemente sulla porta, un autobus in viaggio sulle strade polverose del Messico dalla capitale verso il nord del paese, un ragazzo di nome Hatzin, che ha appena finito la seconda media, chiamato a recuperare una cassa di alluminio.
Dentro c’è quello che rimane del padre, che l’ha abbandonato molti anni prima, in cerca di fortuna e lavoro: in una fossa nel deserto le autorità hanno recuperato i corpi di operai morti chissà quando nelle grandi fabbriche, che lavorano senza sosta, notte e giorno, festivi compresi, perchè c’è una guerra in corso e va combattuta ogni giorno.
Una guerra tra poveri con la manifattura cinese e con quelle operaie dalle mani piccole, che rischiano di rubare ai messicani un pezzo di schiavitù, che chiamiamo lavoro.
Tra i documenti rinvenuti c’è la carta d’identità di Esteban Espinosa Leyva, il padre di Hatzin.
Il ragazzo recupera la cassa e risale sul pullman che lo dovrebbe riportare a casa. Ma lungo la strada gli sembra di vedere un uomo che assomiglia davvero a suo padre.
Scende precipitosamente, chiede informazioni e finalmente si imbatte in quell’uomo, che ora si fa chiamare Mario Enderle.
E’ un caporale senza scrupoli, che lavora per le grandi fabbriche, col sogno di aprire un capannone tutto suo.
 Ogni giorno viaggia con un pick-up e un giovane aiutante, raccogliendo lavoratori disperati, disposti a tutto pur di accumulare qualche giorno di paga.
Ogni giorno viaggia con un pick-up e un giovane aiutante, raccogliendo lavoratori disperati, disposti a tutto pur di accumulare qualche giorno di paga.
Mario nega di essere Esteban, cerca in tutti i modi di mandar via Hatzin, ma non ci riesce. Il ragazzo restituisce addirittura la cassa di alluminio.
Pian piano Mario lo prende sotto la sua ala: il ragazzo è sveglio, sa fa di conto, è attento alle persone, impara in fretta e può essergli d’aiuto.
Quando una ragazza che Mario ha portato in una grande fabbrica fuori dal paese, alza la voce per far valere i suoi diritti e si appella almeno al contratto di lavoro firmato, improvvisamente sparisce.
Per Hatzin sarà la prima di molte progressive incrinature, che lo spingeranno a mettere in discussione il suo ruolo e quello di Mario.
Dopo il Leone d’Oro conquistato con Ti guardo nel 2015, il venezuelano Lorenzo Vigas torna alla Mostra con film che parla ancora di adolescenti, costretti a crescere troppo in fretta.
Il testardo e taciturno Hatzin è deciso a riprendersi quel padre che non ha mai davvero conosciuto e che non è rientrato neppure per il funerale della madre, abbandonandolo al suo destino di orfano.
Quando pensa di riconoscerlo in quell’uomo corpulento che tutti chiamano Mario e che sembra avere un ruolo decisivo nei traffici della zona, le cose si complicano ulteriormente, invece di semplificarsi.
Perchè Mario/Esteban non ha alcuna interesse a fargli da padre, anche perchè la sua vera identità è rimasta sepolta nel deserto.
L’incontro con Mario rappresenterà per Hatzin non solo l’ingresso accelerato nell’età adulta ma anche quello in un mondo oscuro, che nasconde i suoi segreti nella sabbia di un deserto infinito.
Così come la facciata linda e moderna della fabbrica nasconde all’interno un antro ottocentesco di operai e macchine che sbuffano vapore e generano un rumore assordante e ossessivo, così anche la paternità ritrovata richiede un prezzo troppo alto da pagare.
Il film di Vigas è memorabile, essenziale, avvolto dal silenzio e misurato dallo sguardo acuto e innocente del suo protagonista bambino.
La fotografia che rivolta nell’orrore la luminosità della fabbrica e del deserto è di Sergio Armstrong, collaboratore storico di Pablo Larraín.
Straordinario il giovanissimo Hatzín Navarrete, non meno indovinata la scelta di Hernán Mendoza, che era un padre fuori scala anche in After Lucia di Michel Franco.
In quel finale sensazionale nella neve in cui lo spirito di sopravvivenza sembra convivere con il desiderio di Hatzin di riprendersi la sua innocenza, il film di Lorenzo Vigas trova una conclusione capace di chiudere il cerchio solennemente.