“I’ve been a puppet, a pauper, a pirate
A poet, a pawn and a king
I’ve been up and down and over and out
And I know one thing
Each time I find myself flat on my face
I pick myself up and get back in the race”
That’s life, Frank Sinatra
Gotham City, primi anni ’80: Arthur si trucca davanti allo specchio, il cerone sul viso, il rossetto a disegnare un sorriso forzato, gli occhi cerchiati di blu. Mentre la radio rimanda notizie di rivolte e violenze, il clown fa il suo lavoro sulla strada o negli ospedali, cercando di portare gioia in un mondo corrotto e perduto.
Picchiato da un gruppo di ragazzini, poi da un terzetto di yuppies, che lavorano nelle società del magnate Thomas Wayne, Arthur subisce, fino a quando la misura si colma e risponde con la stessa insensibile ferocia.
Straordinario character study, anatomia di un sociopatico, pamphlet politico radicale, omaggio alla New York disillusa e infernale del cinema di Martin Scorsese, il Joker di Todd Phillips è tutto questo e molto di più.
Ma non sarebbe nulla, senza l’ennesima straordinaria interpretazione di Joaquin Phoenix, qui letteralmente scarnificato, consumato da un’esistenza di violenze e abbandoni, di illusioni e opportunità.
 Il suo corpo riflette plasticamente, nella sua prepotente asimmetria, nella sua oscena nudità tutto il dolore che Arthur si porta addosso: sembra uscito da un dipinto di Francis Bacon.
Il suo corpo riflette plasticamente, nella sua prepotente asimmetria, nella sua oscena nudità tutto il dolore che Arthur si porta addosso: sembra uscito da un dipinto di Francis Bacon.
La sensibilità immersiva di Joaquin Phoenix è stupefacente, la sua capacità di nascondersi dentro il personaggio è proverbiale, la sua risata isterica, mista alla smorfia animalesca per cercare di evitarla, restano impresse a lungo.
Arthur è un outsider, un emarginato, a cui nessuno presta attenzione, con o senza la maschera del clown. Soffre di un disturbo neurologico che lo porta a ridere compulsivamente e senza motivo.
Vive con l’anziana madre dopo aver sperimentato anche gli ospedali psichiatrici. I servizi sociali gli danno una mano, finchè il sindaco non taglia i loro fondi. Arthur si guadagna da vivere facendo il pagliaccio, ma sogna di sfondare come stand up comedian: lui e la madre guardano ogni sera in tv il Late Show di Murray Franklin.
Accanto a loro vive Sophie, una madre single con la sua bambina: Arthur immagina di condividerne la solitudine, ma nel suo piccolo mondo non c’è spazio che per l’illusione e la miseria.
Quando infine uno dei colleghi-clown, dopo la prima aggressione, presta a Arthur la sua rivoltella, per difendersi in caso di nuovo attacco, le cose precipitano vorticosamente.
In questo girone infernale chiamato Gotham City, in cui si è persa ogni coordinata morale, resistono quasi solo gli affetti minimi.

Non c’è solidarietà sociale o compassione. Ciascuno è una monade, costretta in una routine irrisolvibile, che sogna il successo, come una sorta di riflesso condizionato del mito americano della seconda possibilità, ma senza più crederci, per davvero.
Arthur scopre improvvisamente che tutto ciò che, a fatica, aveva tenuto nascosto dentro di sè, tutta la violenza nichilistica, il senso di rivalsa, sono l’unica panacea per il suo male di vivere.
La sua vita è stata una sola grande bugia, fin dall’inizio: “Ho sempre pensato alla mia vita come ad una tragedia. Adesso vedo che è una commedia”. In tutta la sua disperazione Arthur diventa così una figura comica, irreale. Ma quando tutto il suo piccolo microcosmo sembra crollare in pezzi, il sapore del sangue è l’unico conforto.
La vittima diventa carnefice, agente provocatore, anarchico capace di diffondere il caos, distruggendo – direttamente o indirettamente – i simboli e gli affetti della sua vita.
Arthur si trasforma così nel Joker, vestito rosso e capelli verdi, ad incorniciare una maschera che non ha più nulla di gioioso.
Eppure, lui sì, è capace di ritrovare, nei panni del suo ultimo personaggio, una leggerezza nuova, un’ebbrezza feroce e bellissima, al tempo stesso.
Può tornare così a sorridere al mondo: “put on a happy face“, gli dice la madre da bambino e Joker ci prova davvero, quando scopre di non essere più solo, ma leader di una rivolta mascherata che, dal basso, ha messo a ferro e fuoco le strade di Gotham.

Il film di Phillips è ambientato nei primi anni ’80, ma il suo sguardo è rivolto ai conflitti che agitano le nostre città oggi, tra un populismo distruttivo e un potere, che si presenta con il volto autoritario e fascista di Thomas Wayne, il milionario che intende candidarsi a sindaco, per ripulire la città dalla sua feccia. Uno che dichiara: “Those of us who have made something of our lives will always look at those who haven’t, and see nothing but clowns.”
Le posizioni si fanno sempre più radicali, le contrapposizioni di classe esacerbano ogni possibilità di provare a comprendersi, lasciando il campo a criminali e vigilanti.
Straordinario e inatteso successo per la Warner, Joker respira lo zeitgeist di questi nostri giorni confusi ed estremi e si presta ad analisi diverse: da quelle più politiche e ideologiche, mantenendo un’ambiguità, che consente letture ugualmente efficaci da destra e da sinistra, a quelle più strettamente sociologiche, psicologiche e sociali, grazie ai molti elementi che arricchiscono il racconto e la caratterizzazione del personaggio: Arthur è un soggetto fragile, abbandonato dai servizi sociali, probabilmente segnato da un trauma infantile, cresciuto solo dalla madre, senza conoscere l’identità del padre.
Ma i manifestanti che mettono la sua maschera sono quelli che ammiriamo di Occupy Wall Street o che si battono per la libertà ad Hong Kong o sono i gilet jeune, forcaioli e oscurantisti, che alimentano l’ondata populista?
Non c’è una risposta sola. Come spesso accade, Joker mi pare abbia acquistato vita propria, sfuggendo alle stesse intenzioni dei suoi autori, entrando in sintonia con il suo pubblico in modi molti diversi e imprevedibili.

Il filosofo Slavoj Žižek ci suggerisce tuttavia una chiave di lettura che mi pare assolutamente condivisibile: “la figura di Joker alla fine, quando si identifica con la sua maschera, è una figura di nichilismo estremo, di violenza autodistruttiva. Non esiste un progetto politico positivo. Il modo in cui dovremmo leggere Joker si trova nel suo astenersi molto saggiamente dal fornire alcuna immagine positiva. […] Alla fine, Joker non è libero. È libero solo nel senso che giunge ad un punto di nichilismo totale. Ho pensato la figura di Joker come una sorta di Kazimir Malevich, l’avanguardista russo, quando ha realizzato il famoso dipinto Quadrato nero. È una specie di protesta minimalista – una riduzione al nulla. […] Non è una figura da imitare. È sbagliato pensare che ciò che vediamo verso la fine del film – Joker celebrato da altri – sia l’inizio di un nuovo movimento di emancipazione. No, è un definitivo punto morto del sistema esistente; una società piegata sulla propria autodistruzione. L’eleganza del film è che lascia a noi il passo successivo di costruire un’alternativa positiva. È un’oscura immagine nichilista pensata per risvegliarci.”
Il film di Phillips azzera inoltre una delle caratteristiche più iconiche della città rinominata Gotham City, ovvero la sua verticalità, il suo skyline celeberrimo, sfruttato sapientemente sia da Burton nei suoi eccessi gotici, sia da Nolan nelle sue panoramiche aree.
Il mondo di Joker è tutto immerso nelle mean streets di periferia, nei club sotterranei, nelle fermate della metropolitana, negli uffici dei servizi sociali con le sbarre alle finestre e nei corridoi di Arkham Asylum. Persino lo studio televisivo di Murray Franklin non ha vedute su Manhatthan.
Non è un caso allora che la trasformazione di Arthur in Joker sia celebrata con un ballo liberatorio sulle scale che conducono al suo appartamento, percorse però in discesa. L’accettazione di quell’underworld di cui diventa simbolo e manifesto è ancora una volta rappresentato attraverso la negazione di ogni possibile ascesa verticale. Nell’impossibilità di alzare lo sguardo, anche solo metaforicamente, Joker si muove così sinuoso, stirando le braccia nervose, inarcando la sua schiena contorta, occupando lo spazio concesso, non quello agognato.

Phillips riscrive la storia dell’antagonista per antonomasia, senza preoccuparsi troppo delle sue precedenti apparizioni cinematografiche e della sua lunga storia negli albi DC.
Joker è un racconto d’origini, ma la definizione gli va stretta. L’intuizione dei due sceneggiatori Phillips e Silver è quella di farne un fratello di sangue di Travis Bickle e di Rupert Pupkin, un uomo perduto e malato, che cerca una salvezza impossibile.
Joker è così contemporaneamente un film d’epoca, perfettamente a suo agio nel nostro tempo, coraggioso nel suo tentativo di indagare l’orrore, che si annida nella deriva della nostre strutture sociali, così come nell’animo e nella psiche di un singolo uomo. L’uno si rispecchia nell’altro, riconoscendosi e alimentando il caos e la rivolta.
Indovinata la scelta della Mostra di tenerlo nel concorso ufficiale, perchè Joker va al di là delle sue origini di genere, evitando quasi completamente l’azione, usando solo pochissimi elementi del canone ufficiale, in favore del ritratto psicologico e dell’affresco politico.
E conquistandosi un posto d’onore, non solo nella wave di eroi e villain, con cui Hollywood ha deciso di raccontare cinematograficamente questi anni, ma anche e soprattutto nella lunga galleria di criminali e gangsters, che hanno fatto la fortuna della Warner Bros sin dagli anni ’30.
Cupa e di angosciante millenarismo la colonna sonora della violoncellista Hildur Gudnadottir, che evoca le atmosfere di Hans Zimmer, senza mai dimenticare la lezione di Johann Johansson. Se That’s life di Frank Sinatra è la canzone che accompagna i sogni di Arthur, il rock di White Room dei Cream diventa quella della rivolta del Joker.
Radicale.
“I’ll wait in this place where the sun never shines
Wait in this place where the shadows run from themselves”
White Room, Cream
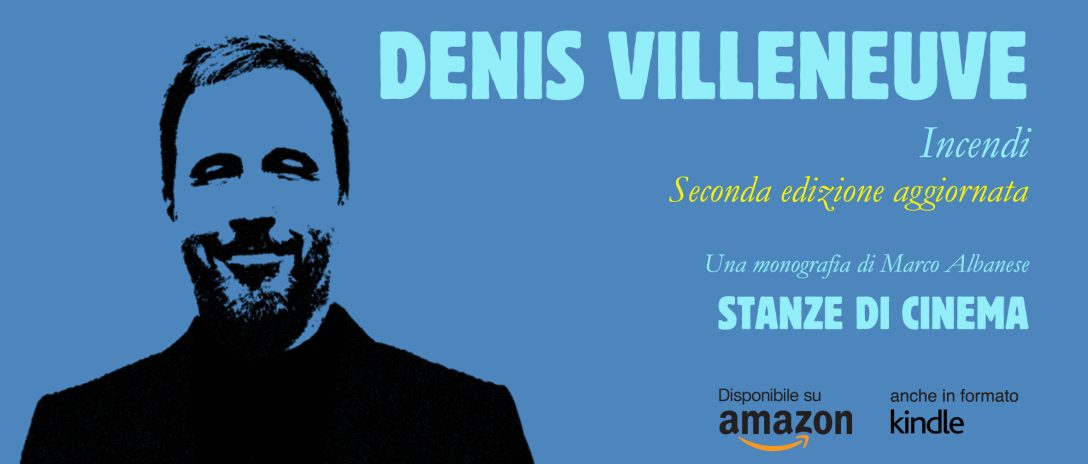




Salve! Ho scoperto per caso questo sito. Molto interessante!
Belle foto e continui aggiornamenti a quanto vedo.
Complimenti.
Grazie mille! Continua a seguirci!
[…] | Marco Albanese @ Stanze di Cinema […]