“C’erano due cose a cui avevo diritto: la libertà o la morte;
se non potevo avere l’una, avrei avuto l’altra”
Araminta Minty Ross nasce schiava nella Contea di Dorchester, nel Maryland del 1822.
Sposata ad un uomo libero, dopo che il suo padrone si rifiuta di affrancarla, rispettando le volontà del padre, piuttosto di essere venduta negli Stati del Sud, decide di scappare nella notte, cercando una fuga impossibile verso Philadelphia.
Anche grazie a quella che sarebbe poi passata alla storia come la underground railroad, Minty raggiunge allo stremo delle sue forze, la Pennsylvania.
Illuminata da visioni mistiche e sostenuta da una fede incrollabile, Minty, che sceglie come suo nuovo nome Harriet Tubman, decide di tornare indietro per liberare la sua famiglia. Tornerà molte altre volte, entrando a far parte di quella rete informale di itinerari segreti e luoghi sicuri, utilizzati dagli schiavi afroamericani, per fuggire negli stati liberi e in Canada con l’aiuto degli abolizionisti.
Le sue imprese le guadagneranno il titolo di Mosè nero.
Il film di Kasi Lemmons è animato dalle migliori intenzioni e dal tentativo di rendere giustizia alla Harriet del titolo, un personaggio complesso, contraddittorio, un’eroina assai poco conosciuta, capace di guidare un plotone durante la Guerra di Secessione e di sopravvivere alle molte taglie, che pendevano sulla sua testa, per morire solo a 91 anni, circondata dalla sua famiglia.
Cynthia Erivo, l’attrice teatrale e cantante, che ha debuttato sul grande schermo solo l’anno scorso con 7 sconosciuti a El Royale e Widows – Eredità criminale, le regala determinazione, testardaggine, ma anche fragilità, dubbi, visioni.
 La Erivo, inglese, di origini nigeriane, è una forza della natura e un volto lontanissimo dalle convenzioni hollywoodiane, perfetto per misurarsi con un ruolo così iconico, eppure molto remoto.
La Erivo, inglese, di origini nigeriane, è una forza della natura e un volto lontanissimo dalle convenzioni hollywoodiane, perfetto per misurarsi con un ruolo così iconico, eppure molto remoto.
Ma Harriet gronda purtroppo di una retorica anche condivisibile, ma che avremmo volentieri evitato: ogni scena è una scena-madre, il carico melodrammatico è sempre altissimo. La musica di Terence Blanchard, di solito elegante, nei suoi lavori per Spike Lee, qui contribuisce sollecitare le solite corde di una facile adesione emotiva.
I flashforward virati di blu, che rappresentano le visioni mistiche della protagonista, sono quanto di più improbabile e imbarazzante si possa immaginare.
Tutto viene ricondotto ad una serie di cliché risaputi: dal padrone bianco feroce e bugiardo, al cacciatore nero ‘venduto’ alla crudeltà dei bianchi, dalla padrona ottusa, alla sorella che non vuole scappare e si accontenta di servire.
Il film si dilunga per oltre due ore, senza mai mostrare quell’urgenza che un personaggio dello spessore della Tubman avrebbe meritato: l’unica scelta di regia è quella di farne un santino, pronto alla beatificazione, affidandosi alla Erivo, per sopperire alle carenze drammatiche.
Il film risulta così fiacco, risaputo, incapace di emozionare davvero, nonostante la Lemmons cerchi solo di far quello.
Se Harriet Tubman ha vissuto con coraggio una vita rischiosa e al servizio della libertà propria e altrui, il film non ha nessuna di queste qualità, conservatore in ogni sua scelta, timoroso di scontentare qualcuno o di non risultare sufficientemente esplicito.
 Meno male che Barry Jenkins, il regista di Moonlight e Se la strada potesse parlare, sta lavorando ad un adattamento del romanzo di Colson Whitehead, La ferrovia sotterranea, che racconterà quegli anni e quelle lotte, sia pure in forma fantastica e filtrate dall’immaginazione del suo autore, in una serie per Plan B e Amazon.
Meno male che Barry Jenkins, il regista di Moonlight e Se la strada potesse parlare, sta lavorando ad un adattamento del romanzo di Colson Whitehead, La ferrovia sotterranea, che racconterà quegli anni e quelle lotte, sia pure in forma fantastica e filtrate dall’immaginazione del suo autore, in una serie per Plan B e Amazon.
Convenzionale.
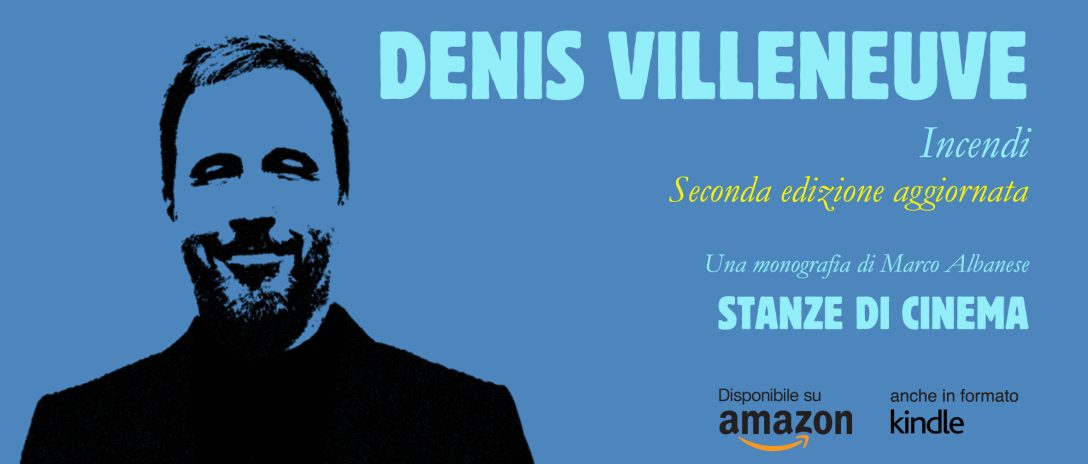



[…] | Marco Albanese @ Stanze di Cinema […]