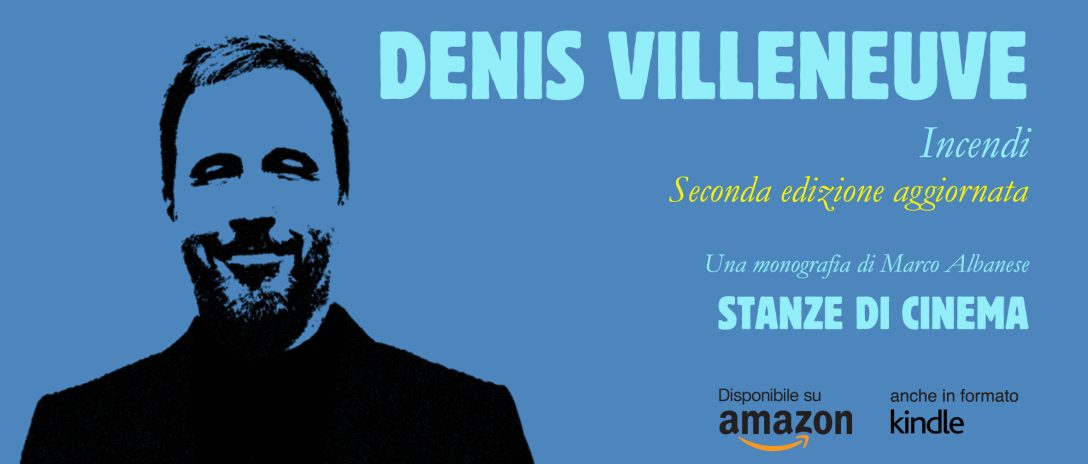Liberamente ispirata al romanzo biografico di Deborah Feldman ‘Unorthodox: the scandalous rejection of my Hasidic roots’, questa miniserie realizzata da Netflix racconta la storia di Esther, una giovane donna ebrea che abbandona il marito e la comunità chassidica dei Satmar a Williamsburg per scappare a Berlino in cerca di libertà e di indipendenza.
Nella comunità ebraica chassidica di Esty l’osservanza scrupolosa della Legge divina pervade ogni gesto quotidiano e si traduce in una forma estrema di auto isolamento. Lo chassidismo è basato su di un forte senso di appartenenza e di condivisione degli eventi quotidiani ed è quindi naturale che sia proprio la comunità ad avere un peso specifico rilevante nel racconto che conduce lo spettatore in uno straniante quanto affascinante viaggio lontano dalla nostra quotidianità e per molti aspetti anche dalla nostra idea di mondo contemporaneo. Durante la visione viene da chiedersi: ma come è possibile che questo avvenga oggi, in una città come New York?
Unorthodox ci racconta un mondo che è a pochi chilometri dalle viste mozzafiato sullo skyline di Manhattan, ma che pare sprofondato in un passato senza tempo: i segnali stradali sono scritti in yiddish, gli uomini vestono sempre in abiti classici (i lunghi rekel) con yarmulke (copricapo circolari) nei giorni feriali e shtreimel (copricapi circolari di pelo) nei giorni festivi e hanno tutti lunghi boccoli lasciati crescere davanti alle orecchie (payot); le donne coprono i capelli, rasati in segno di rispetto verso Dio, con parrucche o foulard colorati. Le interazioni in pubblico tra i due sessi sono limitate, anche nei momenti di festa e le donne sono sottomesse al marito che deve sentirsi “il re” della famiglia. Il mondo esterno alla comunità rappresenta una potenziale minaccia, guardato con sospetto e paura, così come la tecnologia: nelle abitazioni non c’è nemmeno la televisione.
 Lo chassidismo affonda le radici nelle drammatiche condizioni degli ebrei all’interno della Confederazione Polacco-Lituana, dove viveva circa ¾ della popolazione ebraica mondiale. Attaccati prima dai guerrieri nomadi Cosacchi, coinvolti poi nei tentativi di espansione degli Stati confinanti, infine accusati di aver accumulato ricchezze indebite e malvisti per la propria diversità religiosa, gli ebrei furono periodicamente massacrati fino alla fine del diciassettesimo secolo (Pogrom). Durante i Pogrom i villaggi ebraici, gli schtelt, venivano saccheggiati e chi rifiutava di convertirsi era imprigionato ed i suoi beni venivano confiscati, le sinagoghe chiuse ed il Talmùd bruciato sulle piazze.
Lo chassidismo affonda le radici nelle drammatiche condizioni degli ebrei all’interno della Confederazione Polacco-Lituana, dove viveva circa ¾ della popolazione ebraica mondiale. Attaccati prima dai guerrieri nomadi Cosacchi, coinvolti poi nei tentativi di espansione degli Stati confinanti, infine accusati di aver accumulato ricchezze indebite e malvisti per la propria diversità religiosa, gli ebrei furono periodicamente massacrati fino alla fine del diciassettesimo secolo (Pogrom). Durante i Pogrom i villaggi ebraici, gli schtelt, venivano saccheggiati e chi rifiutava di convertirsi era imprigionato ed i suoi beni venivano confiscati, le sinagoghe chiuse ed il Talmùd bruciato sulle piazze.
All’inizio del XVIII° secolo gli ebrei si ritrovavano decimati in un’Europa ancora scossa dalla Guerra dei Trent’anni (1618-1648), di fatto la più drammatica per il mondo occidentale prima della Grande Guerra. Bà ‘al Shem Tov (letteralmente Maestro del Buon Nome) cercò di risollevare lo spirito delle popolazioni ebraiche con una variante della religione tradizionale, lo chassidismo appunto. Nato nel 1700 in Podolia (attualmente tra Ucraina e Moldavia), egli riformò la tradizione ebraica con il principio cardine che il contatto con Dio non si attua solo attraverso la preghiera e lo studio, ma anche con tutte le azioni della vita. Un principio importante in un periodo storico in cui, per quanto descritto, gli ebrei che potevano dedicarsi esclusivamente allo studio e alla contemplazione erano drasticamente diminuiti rispetto al passato.
Nel suo insegnamento Bà ‘al Shem Tov arrivò a tessere l’elogio dell’ignorante, dell’am haaretz, di colui che senza erudizione, ma con devozione e sentimento segue la parola di Dio. Anche per questo motivo lo chassidismo fu inizialmente visto come una forma di devianza dall’ebraismo tradizionale, ponendo l’accento sul sentimento più che sulla dottrina e quindi ridefinendo anche il ruolo dell’autorità rabbinica. Questo però non fermò la diffusione del movimento, anche dopo la scomparsa del Maestro. Furono i Rebbe, guide spirituali, a sviluppare ulteriormente la teologia chassidica e tra le varie comunità assunse presto rilevanza quella di New York, che si insediò già nel 1941 e si rafforzò durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale.
 All’inerzia della comunità e dei suoi membri si contrappone la forza di volontà di Esty. La sua decisione di allontanarsi dai Satmar non è una forma di ribellione a Dio e nemmeno di disprezzo verso quello che la circonda. Il suo turbamento è reale e la sceneggiatura riesce a descrivere con sensibilità il magma di sentimenti contrastanti che si agitano nel cuore di questa ragazza di 19 anni costretta a sposare un uomo con cui aveva a malapena scambiato qualche parola. Esther ha assorbito per anni e quindi introiettato le regole e le convinzioni dei Satmar: se non riesci ad accettare quello che ti viene chiesto dalla Legge è perché tu sei sbagliata. Un senso di inadeguatezza (‘Dio vuole troppo da me’) che inizialmente Esty porta ancora con sé a Berlino ed a cui si sovrappone un forte istinto di libertà, un desiderio di espressione della propria personalità che con il passare del tempo diventa anche di aspirazione alla felicità.
All’inerzia della comunità e dei suoi membri si contrappone la forza di volontà di Esty. La sua decisione di allontanarsi dai Satmar non è una forma di ribellione a Dio e nemmeno di disprezzo verso quello che la circonda. Il suo turbamento è reale e la sceneggiatura riesce a descrivere con sensibilità il magma di sentimenti contrastanti che si agitano nel cuore di questa ragazza di 19 anni costretta a sposare un uomo con cui aveva a malapena scambiato qualche parola. Esther ha assorbito per anni e quindi introiettato le regole e le convinzioni dei Satmar: se non riesci ad accettare quello che ti viene chiesto dalla Legge è perché tu sei sbagliata. Un senso di inadeguatezza (‘Dio vuole troppo da me’) che inizialmente Esty porta ancora con sé a Berlino ed a cui si sovrappone un forte istinto di libertà, un desiderio di espressione della propria personalità che con il passare del tempo diventa anche di aspirazione alla felicità.
Unhortodox è una storia semplice in cui sono fondamentali i personaggi per dare spessore psicologico alle vicende narrate. Il cast è all’altezza delle aspettative: non solo Shira Haas nei panni di Esty, una protagonista convincente che rende anche fisicamente in modo straordinario il mix di fragilità e di coraggio della protagonista, ma anche tutti gli altri personaggi, come il marito Yanky (Amit Rahav), schiacciato dalla comunità in cui vive, esempio di come anche chi è buono può trasformarsi in un carnefice per mancanza di senso critico e di coraggio o il cugino Moische (Jeff Wilbusch) che il coraggio ce l’ha, ma non lo vuole utilizzare preferendo la comodità dell’appartenenza chassidica alla durezza del mondo esterno. Un aneddoto interessante riguarda proprio Jeff Wilbusch che ha abbandonato una comunità ortodossa circa vent’anni fa e si è ritrovato ad interpretare qualcosa di più di un ruolo, ripercorrendo un pezzo della propria vita.
La sceneggiatura descrive con cura ed attenzione i protagonisti e le loro emozioni e riesce a rendere anche interessanti momenti di dialettica, grazie soprattutto al personaggio di Yael (Tamar Amit-Joseph) che evita sistematicamente ogni forma di buonismo nei confronti di Esty e della storia ebraica. Tuttavia la scrittura presenta qua e là delle cadute di attenzione che lasciano perplesso lo spettatore: un’ecografia che rivela un bambino troppo sviluppato per i mesi di gestazione, l’eccessiva facilità nell’introdursi in un edificio o nell’accesso ad una biblioteca specializzata, in generale una vita un po’ troppo semplice a Berlino per una ragazza americana senza alcun reddito. Anche gli interni della casa dei giovani sposi a Brooklyn sembrano più europei che americani.
 Anna Winger, showrunner della serie ha realizzato tra l’altro anche Deutschland 83 e Deutschland 86: questo spiega l’introduzione nella narrazione di una sottile vena thriller relativa alla missione a Berlino di Yanke e Moische per riportare a casa Esty. Una scelta interessante che permette di esplorare meglio due caratteri molto diversi, entrambi espressione della comunità chassidica, a confronto con quello che c’è al di fuori dei confini protetti di South Williamsburg: Hic sunt dracones.
Anna Winger, showrunner della serie ha realizzato tra l’altro anche Deutschland 83 e Deutschland 86: questo spiega l’introduzione nella narrazione di una sottile vena thriller relativa alla missione a Berlino di Yanke e Moische per riportare a casa Esty. Una scelta interessante che permette di esplorare meglio due caratteri molto diversi, entrambi espressione della comunità chassidica, a confronto con quello che c’è al di fuori dei confini protetti di South Williamsburg: Hic sunt dracones.
Merita una citazione la fotografia, diretta con straordinaria cura da Wolfgang Thaler, abilissimo nel modulare la luce naturale per rispondere alla richiesta della regia di armonizzare gli interni con gli esterni attraverso tonalità delicate.
Unorthodox è soprattutto un racconto di libertà, ma lo sfondo religioso ultra-ortodosso consente di ampliare una categoria in cui per troppo tempo si è confinato esclusivamente l’islamismo nelle sue componenti più radicali e conservative. I fondamentalismi sono un pericolo per tutte le religioni ed in generale per tutte le fedi. I tratti comuni sono gli stessi e le persone più esposte sono quelle più fragili, a partire dalle donne e dai bambini. Le sequenze del matrimonio, su cui la sceneggiatura indugia con coraggio, mostrano il passaggio di consegne nella cura della donna, quasi fosse un oggetto o un capo di bestiame. La negazione dell’espressione del sé, della ricerca di una propria strada nel mondo, la paura verso l’altro sono elementi che trasformano i precetti religiosi in obblighi così radicati nella mente delle persone da impedir loro di accettare chi se ne allontana, anche se è uno dei nostri cari. La telefonata che Esty fa alla nonna ed a cui la donna non risponde è drammatica nel mostrare come il ruolo di carceriere sia esercitato dagli stessi membri della comunità, dalle stesse donne.
Il tema dell’estremismo religioso è certamente uno dei più interessanti e sviluppati dalle serie televisive di questi anni, basti pensare al Racconto dell’Ancella, ma questa storia ha una freschezza del tutto particolare perché lancia con tono fermo, ma lieve, un messaggio di speranza verso il futuro.

Un futuro aperto, senza paure.
Titolo originale: Unorthodox
Durata media degli episodi: 55 minuti
Numero degli episodi: 4
Distribuzione streaming: Netflix
Genere: drama thriller comedy
Consigliato: a chi è pronto ad affrontare un viaggio culturale che sembra anche un viaggio nel tempo e per goderne appieno è disposto a soprassedere a qualche limite di verosimiglianza del racconto.
Sconsigliato: a chi cerca serie in cui la sceneggiatura sia sempre attenta ai dettagli e dove il discorso sia ricco quanto la storia.
Visioni parallele: per quanti vogliano continuare ad approfondire il tema dell’ortodossia ebraica, una visione interessante può essere quella di Shtisel, serie Netflix in due stagioni che racconta tra sorrisi e drammi il microcosmo di un quartiere ultra-ortodosso di Gerusalemme. Da vedere, specie per chi ha apprezzato la performance di Shira Haas.
Quanti volessero confrontarsi con la storia vera di Deborah Feldman possono invece leggere la sua autobiografia, pubblicata in Italia con il titolo “Ex ortodossa. Il rifiuto scandaloso delle mie radici chassidiche” per i tipi di Abendstern. Un racconto di emancipazione e libertà.
Un’immagine: quando Etsi si toglie la parrucca e si immerge nell’acqua, una forma di rinascita simile a quella simboleggiata dal Mikvah, una delle abluzioni tradizionali ebraiche che vediamo rappresentata nel secondo episodio. Esistono diverse occasioni dove le regole rabbiniche richiedono l’immersione completa del corpo, ma la differenza è che l’immersione di Etsi nel lago Wansee è una scelta personale ed assume un tratto di piacere sconosciuto alle prescrizioni rituali. Come il rossetto che utilizzerà per la prima volta a Berlino, questa è una Epifania del sé.