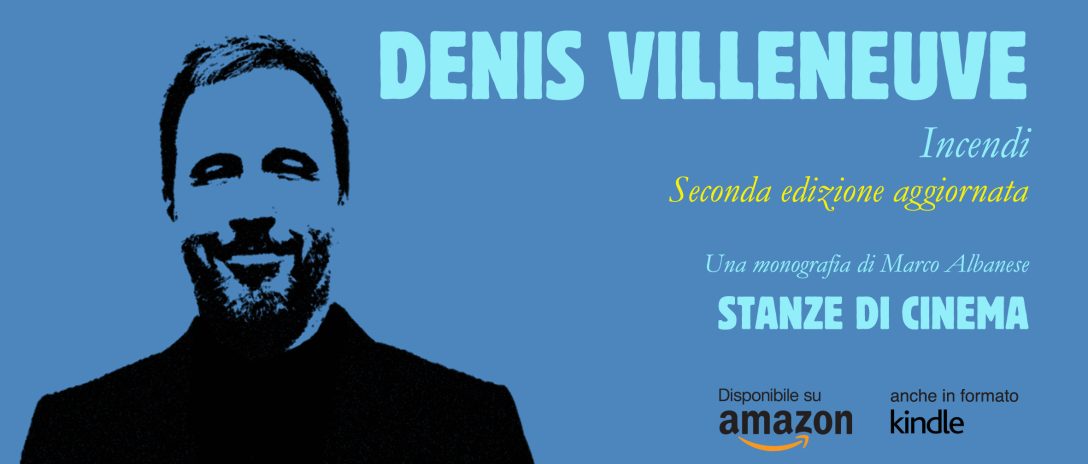Conversazioni con un killer: il caso Bundy **1/2
Conversazioni con un killer: il caso Bundy **1/2
Theodore Bundy è stato accusato di circa 30 omicidi avvenuti in sette diversi Stati degli USA tra il 1974 ed il 1978. Omicidi di giovani donne accompagnati da efferatezza, necrofilia, violenze post-mortem, anche indirette: in alcuni casi il cadavere delle ragazze è stato infatti abbandonato agli animali selvaggi.
Per la consapevolezza del proprio ruolo e per l’esposizione mediatica, molti ritengono Bundy il primo moderno serial killer.
Il fascino di questa mini-serie in 4 episodi sta nel fatto che ci permette di ascoltare la viva voce di Ted Bundy, con i suoi tic, le sue pause, le sue accelerazioni, le sue risate. Registrate da due giornalisti, Stephen G. Michaud e Hugh Aynesworth, sono state circa 150 le ore di interviste sbobinate: le stesse alla base del loro libro Conversation with a serial killer, pubblicato nel 1989.
Accanto alle registrazioni audio ci sono poi i video dei processi e delle dirette televisive dell’epoca, le interviste d’archivio e quelle attuali ai protagonisti delle investigazioni, soprattutto avvocati e poliziotti, ma anche qualche amico di Ted. Meno spazio è lasciato ai famigliari delle vittime. L’esito è un documentario che si segue con piacere, a tratti perfino accattivante, ma che non aggiunge molto a quanto già conosciuto e detto sulla vita di Bundy.
I primi episodi non seguono un ordine lineare, ma procedono con salti temporali. L’infanzia è appena accennata e non vengono approfondite le condizioni molto particolari in cui il piccolo Ted crebbe, trascorrendo parte dell’infanzia con i nonni materni, senza conoscere mai il vero padre e inizialmente pensando che la madre, Eleanor Louise, fosse sua sorella.

Una scelta che di certo farà storcere il naso a quanti attribuiscono particolare valore a questo periodo della vita nella costruzione della personalità e della devianza, ma che dal punto di vista narrativo non pesa sul racconto, anzi lo alleggerisce. Quello che emerge chiaramente dal documentario non è l’infanzia travagliata di Bundy, quanto il fatto che nel raccontarla egli menta in modo sistematico, rimuovendo ogni aspetto negativo e tracciandone invece un quadro quasi idilliaco.
Fin dalle prime battute la ricostruzione socio-culturale appare convincente: l’aumento della violenza in America negli anni ’70 e la forza della repressione che fa seguito alla libertà incondizionata degli anni ’60 è descritta in modo efficace. Se vogliamo in modo sintetico, ma è quello che serve: un inquadramento chiaro delle pulsioni che si muovono nella società americana e di cui Ted Bundy si nutre. Pulsioni per molti aspetti sotterranee e che, quando si concretizzano in atti di violenza, trovano le forze dell’ordine del tutto impreparate, ancora legate ad un’idea di America che non corrisponde alla realtà. Le difficoltà di comunicazione delle forze di polizia sono rappresentate in modo chiaro, come anche l’evoluzione dei meccanismi investigativi, il loro progressivo affinarsi con lo sviluppo tecnologico, ma soprattutto con la consapevolezza della necessità di un maggior coordinamento interstatale per affrontare le nuove sfide della criminalità.
La rappresentazione che il maschio bianco americano ha di sé e del proprio ruolo nella famiglia e nella società si sente in questi anni minacciata, ma più in generale si registra una progressiva perdita di controllo dell’uomo sul mondo. Troppe spinte non riescono più ad essere incanalate dai tradizionali gruppi sociali e quindi, al di là dei disturbi bipolari depressivi di cui sembra soffrisse Bundy, mi sembra rilevante contestualizzare la sua violenza nell’America di quegli anni.
Anche il crescere dell’attenzione e della pressione mediatica si inserisce nel panorama degli anni ‘70: ci troviamo di fronte alla nascita di una nuova società dell’immagine ed è naturale che chi controlla i media detenga un potere rilevante. Il desiderio di apparire è evidente in Bundy, ma non lo è di meno nei procuratori, negli investigatori, nei politici che a più riprese intervengono nelle interviste. Sembra spesso che i protagonisti di questa vicenda siano pervasi dal gusto dell’immagine più che da quello della giustizia.
 Che Ted Bundy fosse intelligente non c’è dubbio, sia a livello sociale che a livello cognitivo. Ascoltarlo è qualcosa che ci trasmette piena consapevolezza della sua abilità retorica e della sua capacità di analisi. Tutti elementi che in realtà hanno fatto perdere parecchio tempo al suo intervistatore, il giornalista Stephen G. Michaud che riuscirà a farlo parlare degli omicidi solamente quando sarà in grado di spostare la prospettiva, convincendo Bundy a parlare di sé in terza persona cioè ad ipotizzare quale potrebbe essere il comportamento di un serial killer mentre compie quel tipo di omicidi, cosa potrebbe provare e come potrebbe essere arrivato a superare la linea. In ogni caso, anche se tutto parte dalle parole di Ted, in modo efficace il documentario alterna l’intervista in carcere al racconto di una compagna di giochi d’infanzia, per dimostrare che gran parte di quello che Ted ci ha appena raccontato è solo una sua percezione distopica, molto diversa da quella degli altri. Appare così il tratto principale del comportamento di Bundy e cioè l’alterazione, la manipolazione, la capacità plastica di modellare le cose e le persone.
Che Ted Bundy fosse intelligente non c’è dubbio, sia a livello sociale che a livello cognitivo. Ascoltarlo è qualcosa che ci trasmette piena consapevolezza della sua abilità retorica e della sua capacità di analisi. Tutti elementi che in realtà hanno fatto perdere parecchio tempo al suo intervistatore, il giornalista Stephen G. Michaud che riuscirà a farlo parlare degli omicidi solamente quando sarà in grado di spostare la prospettiva, convincendo Bundy a parlare di sé in terza persona cioè ad ipotizzare quale potrebbe essere il comportamento di un serial killer mentre compie quel tipo di omicidi, cosa potrebbe provare e come potrebbe essere arrivato a superare la linea. In ogni caso, anche se tutto parte dalle parole di Ted, in modo efficace il documentario alterna l’intervista in carcere al racconto di una compagna di giochi d’infanzia, per dimostrare che gran parte di quello che Ted ci ha appena raccontato è solo una sua percezione distopica, molto diversa da quella degli altri. Appare così il tratto principale del comportamento di Bundy e cioè l’alterazione, la manipolazione, la capacità plastica di modellare le cose e le persone.
L’attenzione dello spettatore viene portata più che sulla crudeltà dei delitti, sul modo che Ted utilizza per mascherarsi e mimetizzarsi: è un bel ragazzo, rassicurante, dalla battuta pronta, che ama vestire in modo elegante e che è impegnato in attività legate alla comunità in cui vive. “Uno di noi” come dice il titolo del secondo episodio. E’ proprio Bundy a ricordarci che non dobbiamo pensare agli assassini come a lupi con la bava alla bocca.
Poco spazio viene lasciato alle vittime e alle loro drammatiche storie. La docu-serie si sofferma piuttosto sui loro tratti di somiglianza fisica e caratteriale: sono tute giovani donne responsabili, impegnate, studentesse di aspetto molto gradevole. Ricordano Stephanie, la prima ragazza di Ted.
La scelta del regista Berlinger è dimostrare che queste ragazze per Bundy rappresentano un genere più che delle persone: la riproposizione insistita delle loro foto va proprio in questa direzione. La conseguenza è però quella di perdere gran parte del brivido perché la prospettiva di Ted e quella delle forze dell’ordine è necessariamente più fredda, meno emotiva e quindi meno coinvolgente.
 E’ questo forse il vero limite del documentario: non fa paura, non terrorizza, non lascia senza fiato come dovrebbe e potrebbe fare la storia di un assassino seriale che ha inflitto tali e tanti dolori e mostrato “tanta indifferenza alla vita umana” come recita la sentenza di condanna della Florida. Più che per i crimini di Bundy si resta senza parole per i festeggiamenti con fuochi d’artificio che tanti bravi cittadini americani fanno il giorno della sua esecuzione.
E’ questo forse il vero limite del documentario: non fa paura, non terrorizza, non lascia senza fiato come dovrebbe e potrebbe fare la storia di un assassino seriale che ha inflitto tali e tanti dolori e mostrato “tanta indifferenza alla vita umana” come recita la sentenza di condanna della Florida. Più che per i crimini di Bundy si resta senza parole per i festeggiamenti con fuochi d’artificio che tanti bravi cittadini americani fanno il giorno della sua esecuzione.
La regia di Joe Berlinger, veterano del genere non fiction (regista di Paradise Lost: the child murders at Robin Hood Hills e Ten Days that unexpectedly changed America) accompagna le parole di Bundy con immagini d’epoca, aumentando il ritmo dei fotogrammi nei momenti in cui il suo linguaggio si fa più concitato e allontanandosi dalla rappresentazione realistica per supportare in modo adeguato le sue esplosioni di violenza. La sequenza finale del primo episodio è a riguardo illuminante e rappresenta uno dei momenti di maggior qualità della mini-serie. Da notare che anche quando si allontana dal realismo, la regia sceglie comunque di utilizzare immagini degli anni ’70.
Il 24 Gennaio del 1989 Theodore Bundy viene giustiziato all’età di 43 anni: il fatto che la sua memoria sia ancora oggi così viva (oltre a questa docu-serie nel corso dell’anno è in uscita anche un film, Ted Bundy – Fascino criminale sempre a firma di Joe Berlinger con Zac Efron) ci dimostra come il suo personaggio sia entrato stabilmente nel nostro immaginario. Forse perché, come ci ricorda lo stesso Berlinger, Ted Bundy ci mette di fronte ad una delle nostre paure primordiali, cioè la paura dell’altro ed al fatto di non conoscerlo mai veramente. Una paura molto attuale in un periodo in cui immagine ed informazione si intrecciano continuamente e le occasioni di manipolazione si sono moltiplicate.
Titolo originale: Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes
Numero degli episodi: 4
Durata media ad episodio: 55 minuti
Distribuzione streaming: Netflix
 CONSIGLIATO: A chi vuole farsi un’idea essenziale e senza retorica di chi fosse Ted Bundy, del suo mondo e dei metodi investigativi della polizia americana tra la fine degli anni ’70 ed i primi anni ’80.
CONSIGLIATO: A chi vuole farsi un’idea essenziale e senza retorica di chi fosse Ted Bundy, del suo mondo e dei metodi investigativi della polizia americana tra la fine degli anni ’70 ed i primi anni ’80.
SCONSIGLIATO: A chi conosce bene la storia di Ted Bundy e che ha già dimestichezza con il suo mondo distopico. A chi cerca emozioni forti: la serie è piuttosto avara di ricostruzioni immersive e punta piuttosto alla descrizione fredda e distaccata, senza enfasi, ma anche senza pathos.
VISIONI PARALLELE:
Mindhunter, serie Tv 2017. Anche in questo caso c’è di mezzo il buon vecchio registratore ed un serial killer che racconta la propria esperienza. La serie diretta (tra gli altri) da David Fincher è ambientata nei tardi anni’ 70 ed è tutta basata sull’indagine: quella profonda che coinvolge in modo pesante non solo l’indagato, ma anche l’indagatore. Poche scene di violenza tradizionale, molta tensione e introspezione. In arrivo la seconda stagione.
Uno sconosciuto al mio fianco di Ann Rule, ed. Tea 2016. Il libro è il racconto di Ann Rule cioè una donna che ha conosciuto da vicino uno dei più famosi serial killer della storia. Ann e Ted lavoravano insieme in un servizio di assistenza telefonica per le persone in difficoltà. Ann per diversi anni ha creduto alla sua innocenza, fino a rendersi conto di avere al proprio fianco un estraneo, “un sociopatico che traeva piacere dal dolore altrui”.
UN’IMMAGINE: quando il giudice della Florida Edward D. Cowart condanna Ted Bundy a morte e mentre gli legge la sentenza aggiunge: “E’ una tragedia che questa corte abbia visto un così totale spreco di umanità, o almeno io la penso così. Sei un giovanotto brillante. Saresti stato un ottimo avvocato e mi sarebbe piaciuto confrontarmi con te, ma tu hai scelto un’altra strada. Prenditi cura di te, giovanotto”.