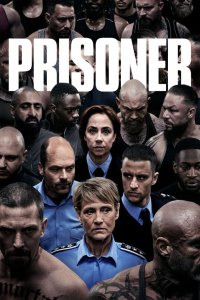“La vita è una prigione all’aperto” (R. W. Fassbinder).
Nell’ambito del sempre intrigante genere carcerario, si può tranquillamente affermare che la danese Prisoner (Huset), ora disponibile sulla piattaforma MyMovies ONE, si piazzi tra le migliori produzioni seriali di sempre. Prisoner, presentata con successo a Canneseries nel 2023, è stata fin da subito apprezzata dalla critica specializzata, tanto da essere insignita nello stesso anno del Prix Italia come miglior dramma televisivo. Creata da Kim Fupz Aakeson, Frederik Louis Hviid e Michael Noer, gli ultimi due anche registi degli episodi, la serie può contare su un cast eccezionale, interamente di marca nordeuropea, e sull’apporto artistico di Martin Juel Dirkov, il compositore delle colonne sonore di The Apprentice e Holi Spider. Notevole anche la resa della fotografia, affidata a Adam Wallensten, già collaboratore di Noer in Birthday Girl e di Hviid in The Quiet Ones, oltre ad aver lavorato dietro le quinte di The Last of Us.
Il giovane Samir (interpretato dall’emergente Youssef Wayne Hvidtfeldt), alias Sammi, al suo primo giorno di lavoro nell’obsoleto penitenziario situato alla periferia di Copenaghen e chiamato informalmente Huset, cioè la Casa, prova subito ad applicare uno tra i numerosi insegnamenti appresi in accademia. Le chiavi appese alla cintura, soprattutto nel corso di una perquisizione, vanno tenute strette – questo ha imparato la matricola neoassunta – perché farle tintinnare, magari anche distrattamente, è un modo sbagliato di operare. Ma il veterano Henrik (David Dencik, già Gorbačëv in Chernobyl), il collega che lo accompagna, è di diverso avviso. Henrik sa che il rumore inconfondibile delle chiavi segnala ai detenuti la prossima irruzione delle guardie ed è molto meglio così, per tutti.
 Sammi, arrivato con l’obiettivo ambizioso di fare la differenza, imparerà presto l’esistenza di regole non scritte. L’importanza fondamentale attribuita alla negoziazione (tra guardie e carcerati, s’intende) per fissare le condizioni utili a mantenere un clima di pace all’interno della struttura, sarà per lui una scoperta dura da digerire. Tuttavia, l’alternativa data dal sistema è tra l’adattarsi e il morire. Cosa scegliere, quindi?
Sammi, arrivato con l’obiettivo ambizioso di fare la differenza, imparerà presto l’esistenza di regole non scritte. L’importanza fondamentale attribuita alla negoziazione (tra guardie e carcerati, s’intende) per fissare le condizioni utili a mantenere un clima di pace all’interno della struttura, sarà per lui una scoperta dura da digerire. Tuttavia, l’alternativa data dal sistema è tra l’adattarsi e il morire. Cosa scegliere, quindi?
Le due protagoniste femminili rispondono ai nomi di Miriam e Gert, interpretate rispettivamente da Sofie Gråbøl, attrice cara a Lars von Trier, nota soprattutto per il ruolo dell’ispettore Sarah Lund in The Killing e da Charlotte Fich, celebre in patria per Rejseholdet (Unit One), serie di matrice poliziesca dei primi anni duemila. Prisoner mostra il lato privato dei personaggi principali. Miriam si ritrova suo malgrado a dover ripianare i debiti del figlio Asger, tossicodipendente di lungo corso e in procinto di diventare padre. L’inquadratura di spalle, mentre lavora in casa da sola con la macchina da cucire, ci permette di notare un’orrenda ustione sul suo corpo, probabilmente il retaggio di un’aggressione con l’olio bollente patita in passato. Gert, guardia di rango superiore, deve prestare assistenza a un marito colpito da demenza senile, reso violento dalla malattia, oltre a sfidare il dolore del lutto per un figlio morto in guerra.
Umani, fatti di carne e sangue, i quattro principali protagonisti di Prisoner attraversano, giorno per giorno, un deserto morale punteggiato di piccole e grandi sofferenze, sperando di sopravvivere al duro rancore dei detenuti e anche alla propria, intima rabbia repressa.
 L’ambiente di lavoro non offre consolazioni e amplifica a dismisura ogni disagio, latente o conclamato che sia. Tutte le mattine, dopo aver superato l’esame del metal detector e le forche caudine delle possibili perquisizioni (nessuno è potenzialmente indenne da sospetti), i colleghi si augurano a vicenda di passare una buona giornata noiosa. La noia, in questo caso, è la filigrana di un turno tranquillo. L’osmosi interna, raggiunta mediando illegalmente con la controparte rappresentata da carcerati di spicco, soggetti condannati per crimini legati, in particolare, al traffico di droga (tranne il colletto bianco Helge), svanisce quando la Direzione centrale assume la decisione di sopprimere un penitenziario. Nella rosa di strutture candidate alla chiusura, ristretta a tre, c’è la Casa.
L’ambiente di lavoro non offre consolazioni e amplifica a dismisura ogni disagio, latente o conclamato che sia. Tutte le mattine, dopo aver superato l’esame del metal detector e le forche caudine delle possibili perquisizioni (nessuno è potenzialmente indenne da sospetti), i colleghi si augurano a vicenda di passare una buona giornata noiosa. La noia, in questo caso, è la filigrana di un turno tranquillo. L’osmosi interna, raggiunta mediando illegalmente con la controparte rappresentata da carcerati di spicco, soggetti condannati per crimini legati, in particolare, al traffico di droga (tranne il colletto bianco Helge), svanisce quando la Direzione centrale assume la decisione di sopprimere un penitenziario. Nella rosa di strutture candidate alla chiusura, ristretta a tre, c’è la Casa.
Con le nuove leggi cambia l’approccio nella gestione del carcere. Aumentano le perquisizioni ed è richiesta una maggiore efficienza misurabile in quantità di droga sequestrata. Le gerarchie ne risentono e così i ritmi e le intese faticosamente raggiunte. Come spiega Henrik a Sammi durante il primo giro esplorativo (nell’occasione già si percepisce una totale mancanza di sintonia umana e professionale tra i due), gli ospiti della prigione sono suddivisi in sezione rossa e sezione blu. In quella rossa comanda Panik, che sfodera con orgoglio una bandiera danese tatuata sul collo, in quella blu il capo è un certo Hulk.
La divisione rispecchia una spaccatura netta, di stampo grezzamente etnico, tra detenuti locali e immigrati. Questi ultimi, in maggioranza arabi, sulla base dei rapporti di forza si posizionano un gradino al di sotto di Panik e soci, ma godono comunque di concessioni in ordine alla gestione del traffico di sostanze illecite. La spartizione tacita delle aree di influenza genera un clima di pace armata. Nella Casa, un inferno composto da gironi, la sopraffazione del forte sul debole è la regola.
 Con la complicità di Henrik e altre guardie accondiscendenti, hashish e steroidi entrano senza problemi tra le mura del carcere. La droga è l’anestetico perfetto (“li rende tranquilli”) e l’organizzazione, da chi fabbrica le bustine a chi le distribuisce, fino alla riscossione, è degna di una filiera imprenditoriale. Panik governa ampie parti di prigione, schiacciando sotto il tallone dei debiti contratti tutti i consumatori abituali, in genere i più fragili, i carcerati “semplici” messi dentro per crimini minori, soggetti psichicamente labili.
Con la complicità di Henrik e altre guardie accondiscendenti, hashish e steroidi entrano senza problemi tra le mura del carcere. La droga è l’anestetico perfetto (“li rende tranquilli”) e l’organizzazione, da chi fabbrica le bustine a chi le distribuisce, fino alla riscossione, è degna di una filiera imprenditoriale. Panik governa ampie parti di prigione, schiacciando sotto il tallone dei debiti contratti tutti i consumatori abituali, in genere i più fragili, i carcerati “semplici” messi dentro per crimini minori, soggetti psichicamente labili.
Sammi ritrova Benji. Da ragazzi condividevano una vita randagia, marginale, tra genitori assenti, incroci ricorrenti con la malattia mentale e incontri infelici (Sammi era per tutti lo “strano”). Dopo una “spaccata” finita male, Benji finì in riformatorio, senza spifferare mai il nome dell’amico. Per lui fu l’inizio di una discesa verso il basso, inclusa una sosta nell’inferno manicomiale. Ora, “ospite” di una cella del settore rosso, Benji si è convertito all’Islam, mosca bianca tra gli arabi. La separazione dalla fidanzata Ariana, la fidanzata che va a trovarlo sempre controvoglia, lo devasta. Il dolore si radica nella testa. Le emicranie sono insopportabili.
I due ex compagni di rapine sono personaggi simmetrici e complementari. Sammi, di padre marocchino, non è credente, non parla la lingua del Corano e diffida dei suoi “fratelli”. Anziché proteggere Benji, nonostante lo stato di salute visibilmente precario, decide di servirsene, di trasformarlo in un informatore (l’equivalente del topo di fogna nel ranking carcerario) per colpire Hulk e Panik, i cosiddetti “adulti”. In cambio, gli promette una rapida libertà condizionata, che non arriverà mai. Non è chiaro cosa muova Sammi, anche nella relazione pericolosa con Ariana, se ambizione personale o cinico pragmatismo finalizzato alla salvezza del penitenziario. Sammi è una figura persa nei chiaroscuri, meravigliosamente definita, pur nei suoi contorni necessariamente ambigui, dal talento di Youssef Wayne Hvidtfeldt.
 Henrik, l’uomo del compromesso con Panik, è l’altro grande protagonista maschile della serie. Vibrante e nervoso, per ripristinare l’ordine non esita a usare violenza nei confronti dei carcerati indisciplinati (etichettati in rosso sulla grande lavagna appesa in ufficio). Ogni azione fuori dagli schemi è facilmente “coperta”. Non è forse vero che una volta in galera si scivola facilmente?
Henrik, l’uomo del compromesso con Panik, è l’altro grande protagonista maschile della serie. Vibrante e nervoso, per ripristinare l’ordine non esita a usare violenza nei confronti dei carcerati indisciplinati (etichettati in rosso sulla grande lavagna appesa in ufficio). Ogni azione fuori dagli schemi è facilmente “coperta”. Non è forse vero che una volta in galera si scivola facilmente?
Prisoner mostra un inusuale puntiglio nel mostrare i dettagli tecnici. Assistiamo, ad esempio, a lezioni di difesa “illegali”. Proprio Henrik è il responsabile della tragica morte di Ghaleeb a seguito di un leglock, una mossa esercitata a terra che può portare al soffocamento (riecheggia tra le mura quel “non riesco a respirare” eletto a slogan dal Black Lives Matter). La vicenda familiare di Henrik è caratterizzata da un difficile presente. Gli aspetti sociologici riescono a essere precisi e spietati. Una casa invasa dalla muffa, un figlio bullizzato dai compagni di scuola, un matrimonio ridotto ai minimi termini, un segreto pronto ad esplodere…
Protagonista è il corpo. Quello dei nuovi arrivati nella Casa, denudato per i controlli di rito. Quello delle visitatrici, ispezionato in una stanza isolata. Quello di Tommy, fonte dei turbamenti di Henrik. Quello di Miriam, sfregiato e nascosto. Quello esibito di Panik, tatuato e muscoloso. Protagonista è il corpo elettrico, scosso dall’astinenza, oppure trasformato in “autocisterna”, perché forzato a introiettare droga nelle parti meno accessibili. Protagonista è anche la pioggia, incessante, apparentemente eterna. La Danimarca ritratta nella serie è inchiodata, quasi ontologicamente, a un’assenza di sole.
 Prisoner, in un riuscito gioco sinestetico, riesce a farci percepire gli umori in circolo. Quando Miriam porta con sé la droga e gli aghi per conto di Khaled, il suo ricattatore nonché spacciatore di fiducia dello sciagurato Asger, quasi sentiamo l’odore della paura. La scena in cui cerca di fuggire dal fiuto infallibile del cane poliziotto è di grande intensità. La sua corsa nel finale per salvare Benji, nel cuore della rivolta, ha qualcosa di distopico. È un mondo ribaltato e insieme coerente, perché basato su un gioco di forze sistemico e disumano. L’espressività di Sofie Gråbøl, nei frangenti di maggiore tensione, è fantastica. La regia ricorre ai buoni vecchi strategemmi. Le inquadrature, in particolare i frequenti primi piani, colgono infatti la centralità dei vari personaggi, mentre sullo sfondo scorre un mondo ripetitivo e freddo.
Prisoner, in un riuscito gioco sinestetico, riesce a farci percepire gli umori in circolo. Quando Miriam porta con sé la droga e gli aghi per conto di Khaled, il suo ricattatore nonché spacciatore di fiducia dello sciagurato Asger, quasi sentiamo l’odore della paura. La scena in cui cerca di fuggire dal fiuto infallibile del cane poliziotto è di grande intensità. La sua corsa nel finale per salvare Benji, nel cuore della rivolta, ha qualcosa di distopico. È un mondo ribaltato e insieme coerente, perché basato su un gioco di forze sistemico e disumano. L’espressività di Sofie Gråbøl, nei frangenti di maggiore tensione, è fantastica. La regia ricorre ai buoni vecchi strategemmi. Le inquadrature, in particolare i frequenti primi piani, colgono infatti la centralità dei vari personaggi, mentre sullo sfondo scorre un mondo ripetitivo e freddo.
Nell’area del penitenziario, una zona di esclusione dove lo stato di eccezione è appena dietro l’angolo, l’ordine deve essere fatto rispettare. Le regole di comportamento sono riportate ai semplici meccanismi foucaltiani del sorvegliare e punire, anche a causa di basilari esigenze di budget (frequente l’accenno alla carenza di organico) che non permettono di avviare attività alternative. Le persiane sui vetri della guardiola, smantellate di propria iniziativa dal diligente Sammi, corrispondono a uno sguardo sugli altri che qualcuno vorrebbe amputare. E con lo sguardo, la responsabilità verso i più deboli.
 Interno ed esterno si confondono. Prisoner racconta il declino di una professione, che corrisponde, a voler seguire gli insegnamenti illuministici del Beccaria, al declino di una civiltà. La funzione delle guardie è chiaramente stabilita, eppure Gert, Miriam, Henrik e Sammi sono incarcerati anch’essi, nelle loro vite di ogni giorno. Qualcuno sacrifica onore e dignità, infangando la divisa, per salvare sé stesso o i propri cari. L’assoluzione dei responsabili della morte di Ghaleeb, decisa dall’alto e confortata da un’autopsia parziale, innesca il caos. I quattro nomi scritti sui muri sono una sentenza. Danesi e arabi si compattano contro Henrik e i suoi colleghi, secondo una logica dicotomica di amico e nemico.
Interno ed esterno si confondono. Prisoner racconta il declino di una professione, che corrisponde, a voler seguire gli insegnamenti illuministici del Beccaria, al declino di una civiltà. La funzione delle guardie è chiaramente stabilita, eppure Gert, Miriam, Henrik e Sammi sono incarcerati anch’essi, nelle loro vite di ogni giorno. Qualcuno sacrifica onore e dignità, infangando la divisa, per salvare sé stesso o i propri cari. L’assoluzione dei responsabili della morte di Ghaleeb, decisa dall’alto e confortata da un’autopsia parziale, innesca il caos. I quattro nomi scritti sui muri sono una sentenza. Danesi e arabi si compattano contro Henrik e i suoi colleghi, secondo una logica dicotomica di amico e nemico.
Prisoner punta al cuore della questione politica. Le nuove direttive governative introducono un elemento di pura perversione. Se i sequestri di sostanze illecite significano efficienza, allora è un bene che la droga circoli tra le celle. Cosa accade oggi nei centri di correzione? Il degrado umano, morale e professionale è colpa del “solito” capitalismo? Oppure sono gli algoritmi del marketing elettorale a decidere, in sostituzione dei governi? O, ancora, è direttamente la pancia del populismo a parlare? La decisione di selezionare il penitenziario da chiudere, non a caso, somiglia a un reality sinistro, con i connessi punteggi. Le parole finali di Gert di fronte agli ispettori reclamano più guardie, più interazione, più ascolto.
“Il carcere”, scrive Jean Genet in Miracolo della rosa, “è un luogo che alleggerisce e appesantisce al contempo. Tutto ciò che lo concerne, persone e cose, ha la pesantezza del piombo e la nauseante leggerezza del sughero. Tutto è pesante perché tutto sembra sprofondare in un elemento opaco, dai movimenti lentissimi. Si è caduti lì proprio perché troppo pesanti… Ci siamo lasciati inghiottire.” E anche noi possiamo sprofondare nei dolenti meandri di Prisoner, serie immersiva di grande impatto lirico.
Numero di episodi: 6
Durata: 60 minuti l’uno
Distribuzione: MyMovies ONE
Uscita in Italia: 10 ottobre 2025
Genere: Prison Drama
Consigliato a chi: non dimentica mai di indossare la cravatta, è considerato un portavoce nato, farebbe di tutto pur di mangiare le ostriche.
Sconsigliato a chi: cerca la sorpresa negli ovetti di cioccolata, ha messo la mano sulla piastra accesa, sostituirebbe il padel con il badminton.
Ascolti e letture parallele:
La resistenza mentale di Jarvis Jay Master nel carcere di San Quintino: Il buddhista nel braccio della morte, Ubiliber (audiolibro).
Goliarda Sapienza racconta il tempo della sua reclusione: L’università di Rebibbia, Einaudi, 2016.
Nell’infinita produzione cinematografica sul tema, suggeriamo: Il Profeta di Jaques Audiard (2009), disponibile su varie piattaforme.
Un disturbo che diventa una metafora: la dislessia di Sammi.